Presente storico
TRINARICIUTI
ENZO R. LAFORGIA - 01/03/2018
Fa uno strano effetto, a noi, generazione del secolo scorso, passare davanti agli spazi allestiti per accogliere i manifesti elettorali e vederli quasi tutti vuoti. La brutta e noiosa campagna elettorale che si è appena conclusa, probabilmente ha avuto un solo pregio: quello di essere stata relativamente breve. Pare che i candidati, questa volta, abbiano puntato quasi esclusivamente su quegli ambienti virtuali che chiamano social network. Dove peraltro si limitano a curare la propria immagine, senza entrare in relazione con i potenziali elettori. Certo, anche per una questione economica, le nostre città sono state tappezzate molto meno del solito da lenzuolate di carta, con facce rassicuranti e sorridenti (ma non troppo). E così la campagna elettorale, come del resto la politica di quelle che un tempo erano grandi organizzazioni di massa, è svaporata: coloro che aspirano ad occupare un seggio in Parlamento o in Regione hanno puntato tutto sull’autopromozione. Molto meno su quelle che un tempo si chiamavano “idee” e che poi sono diventati “programmi”.
Noi, invece, generazione del secolo scorso, ricordiamo (senza rimpianto, però) quando le campagne elettorali si consumavano nelle piazze, tra persone fisiche, fatte di carne, ossa, frattaglie e molti atomi. Non avatar digitali fatti di bit.
Ricordate i vecchi comizi? Veri e propri spettacoli!
Luciana Viviani (1917-2012), figlia di Raffaele Viviani, grande autore di teatro, così racconta il suo primo comizio a Napoli, durante la campagna elettorale della primavera del 1946:
«[…] mi è stato assegnato un balcone: una condizione di grande privilegio, abituati come siamo, noi comunisti, a dover parlare chiedendo in prestito una sedia a una bottega oppure, difronte ai frequentissimi rifiuti, arrampicandoci su qualche muretto o utilizzando qualche fortunosa gradinata.
In questi comizi si parla ovviamente a voce nuda, ma su quel balconcino trovo addirittura un microfono.»
Luciana Viviani, già partigiana e destinata a rivestire per vent’anni il ruolo di deputata, parla per più di un’ora contro la monarchia e a favore della Repubblica, in una Napoli quasi interamente schierata al fianco del principe Umberto, il re di maggio. Tiene il suo comizio di fronte ad una marea umana bicefala, perché ogni spettatore sorregge un bastone su cui troneggia (è il caso di dire) la testa del re: quello che da poco ha abdicato o quello che tra poco sarà costretto ad abbandonare l’Italia. Alla fine del comizio, «il silenzio della piazza si fa ancora più pesante».
Ai successivi appuntamenti elettorali, la macchina della propaganda andò perfezionandosi. È ancora la Viviani a ricordare come funzionava, nel momento in cui si dovevano battere i territori, anche quelli più impervi e isolati:
«Ogni pomeriggio, alle prime ore, partivano le auto staffetta, tante quante ne aveva a disposizione ogni centro base. Su ogni auto salivano quattro o cinque oratori, ciascuno destinato a una delle località situate sul percorso studiato degli organizzatori emiliani o lombardi.
Le auto, cariche di auto e di acciacchi, percorrevano strade deserte e accidentate, con lunghi tratti di strada bianca, senza un albero per chilometri e chilometri, senza case, ma solo con gruppi di pecore con il loro solitario pastore. […]
Via via che l’auto raggiungeva uno dei paesi in elenco si alleggeriva del peso di uno dei suoi occupanti. Sbarcava il “pioniere della parola” con il suo bagaglio di piccole informazioni, la sola bussola per navigare in quel mare sconosciuto.»
Come si sa, la campagna elettorale per elezioni del primo Parlamento della Repubblica, quelle del 18 aprile 1948, fu decisamente dura nei toni e spesso violenta nei modi. La posta in gioco era molto più grande di una maggioranza parlamentare, perché riguardava la collocazione del nostro Paese nel più vasto e complicato scenario della Guerra fredda. In quella occasione, davvero le forze politiche ricorsero per la prima volta a mezzi, strumenti e temi di propaganda inediti per l’Italia. Manifesti, volantini e gadget di vario tipo invasero i muri e le strade; la Chiesa mobilitò le parrocchie, oratori seduttivi come il gesuita Riccardo Lombardi, «il microfono di Dio», scomodò persino la Madonna, trasformandola in una Madonna pellegrina; i partiti, tutti, si ingegnarono nel trovare soluzioni grafiche accattivanti ed incisive, slogan ad effetto, appropriandosi di simboli che appartenevano all’immaginario comune, da Garibaldi al Tricolore.
Così Enzo Bettiza, nel romanzo La campagna elettorale, del 1953, descrive le novità rappresentate dalla propaganda politica di quella stagione:
«Fuori il 18 aprile incalzava davvero. La città negli ultimi giorni si era trasformata. Era la seconda volta, dal 2 giugno, che si faceva la politica anche noi all’americana, a colpi di cartaccia variopinta. Coriandoli scintillanti indugiavano a spruzzi nel cielo. Rossi e verdi o bianchissimi, schizzavano per le nuvole come schegge di sole. Giù per le strade assordavano le voci chiocce, strozzate, che uscivano attraverso i megafoni dalle macchine tentennanti a passo d’uomo attraverso crocchi di gente insonne, eccitata, confabulante nelle piazze, agli angoli, dappertutto. Sui muri, immobili, i pupazzi. Occhi dita smorfie alla strada, pendevano cosacchi, dattilografe formose, unghie sanguinolenti sul Vesuvio, Cristo di nuovo in croce, e quegli stracci di carne da Buchenwald. Ho visto anche, contorto a un fildiferro spinato, tracciato sul nero con il gesso, uno scheletro […].»
Anche da noi era arrivata «la politica all’americana», che avrebbe caratterizzato anche la tornata elettorale (sempre infuocata) del 1953, su cui gravava l’incognita della cosiddetta «legge truffa». Fu in quella occasione che la propaganda delle sinistre scelse di rappresentare i democristiani come “forchettoni”, uomini, cioè, dal bulimico appetito. Dall’altra parte, non erano certo più teneri. Forse qualcuno ancora ricorda il segno graffiante e le trovate geniali di Giovanni Guareschi, che rappresentava i comunisti come trinariciuti, dotati, cioè, di una terza narice, la cui funzione era «completamente indipendente dalle altre due: serve di scarico in modo da tener sgombro il cervello dalla materia grigia e permette nello stesso tempo l’accesso al cervello delle direttive di partito che, appunto, debbono sostituire il cervello che appartiene oramai a un altro secolo…»
Guareschi, fazioso ma intelligente, sapeva bene che codesta terza narice non era in dotazione solo ai comunisti:
«Naturalmente la terza narice non è una strettissima prerogativa delle sinistre: io credo che ce ne siano molte altre, distribuite un po’ in ogni dove: quanta gente ha la terza narice e non lo sa ancora? Le confesso che anch’io, alle volte, rileggendo quello che ho scritto e che purtroppo ho già stampato mi guardo perplesso nello specchio. Attenti dunque alla terza narice!»
Ma il clima stava già cambiando. Le speranze di una profonda trasformazione della società erano sempre più sbiadite, man mano che ci si allontanava dalla stagione resistenziale e si rimaneva impantanati nella stagione del centrismo.
Probabilmente il ritratto più amaro di quel clima psicologico ci è stato offerto dal romanzo di Calvino, La giornata di uno scrutatore, la cui vicenda si svolge in un seggio elettorale, proprio in occasione delle elezioni politiche del 1953, allestito presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, conosciuta anche come Cottolengo. Le solide convinzioni di Amerigo Ormea, comunista, si scontrano e sembrano un po’ vacillare di fronte all’umanità sofferente ospitata presso quell’istituto e intorno alla quale si tessono intrighi e imbrogli.
Ma tutto questo, tutto quello che abbiamo rievocato, oggi sembra non esistere più. La politica preferisce i luoghi chiusi alle piazze, i salotti televisivi alle strade, l’esaltazione della singola personalità alle idee, i bit agli atomi. Una sola cosa è certamente sopravvissuta della politica del secolo scorso: una considerevole presenza di trinariciuti.

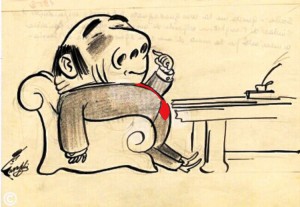
You must be logged in to post a comment Login