Stili di Vita
ROMANZO FILOSOFICO
VALERIO CRUGNOLA - 26/06/2015
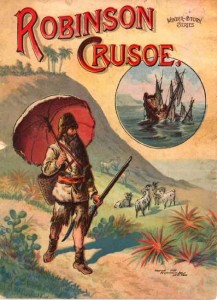 Se è vero che la pratica di una vita filosofica si attua, come pensiamo, attraverso una serie di «esercizi spirituali», non necessariamente finalizzati a un risultato specifico, ma anzi il più delle volte non cercato ma cόlto e quasi strappato al caso, allora la letteratura ci offre una delle migliori opportunità. Non possiamo vivere altre vite oltre a quella che viviamo; ma la letteratura ha il pregio di moltiplicare, teoricamente in modo infinito, le nostre opportunità di entrare in una vita altrui, di farla nostra, se non altro come esperienza intellettuale, di affacciarci a una finestra aperta sull’esistenza, oltre i vincoli dello spazio e del tempo, e di trarne così, oltre al piacere suscitato in noi dalla bellezza del testo, opportuni nutrimenti o insegnamenti.
Se è vero che la pratica di una vita filosofica si attua, come pensiamo, attraverso una serie di «esercizi spirituali», non necessariamente finalizzati a un risultato specifico, ma anzi il più delle volte non cercato ma cόlto e quasi strappato al caso, allora la letteratura ci offre una delle migliori opportunità. Non possiamo vivere altre vite oltre a quella che viviamo; ma la letteratura ha il pregio di moltiplicare, teoricamente in modo infinito, le nostre opportunità di entrare in una vita altrui, di farla nostra, se non altro come esperienza intellettuale, di affacciarci a una finestra aperta sull’esistenza, oltre i vincoli dello spazio e del tempo, e di trarne così, oltre al piacere suscitato in noi dalla bellezza del testo, opportuni nutrimenti o insegnamenti.
All’interno dei generi letterari, un posto peculiare spetta ai romanzi filosofici. Non necessariamente, questo genere è programmatico (come nel Candide di Voltaire), o addirittura volutamente didascalico (come nelle Avventure di Telemaco di Fénelon). L’intraprendenza del Robinson Crusoe di Defoe, lo scetticismo corrosivo dei Viaggi di Gulliver di Swift, le vicende del Wilhelm Meister di Goethe e di altri consimili «romanzi di formazione», possono valere quanto la Ricchezza delle Nazioni di Smith, i Saggi di Montaigne, la Fenomenologia dello Spirito di Hegel. Semplificando e rendendo più immediata un’argomentazione filosofica, la letteratura ha il pregio di tradurla in una narrazione, di incarnarla in personaggi che la rendono viva, di risultare così più prossima al campo dei nostri vissuti e di insegnarci direttamente qualcosa, stimolandoci a riflettere muovendo da intuizioni anziché da registri linguistici di tipo strettamente razionale. Non per nulla tragedie come l’Antigone di Sofocle o i romanzi di Dostoevskij figurano ormai con appositi paragrafi o capitoli nei migliori manuali di storia del pensiero filosofico.
Qualcosa di analogo, naturalmente, vale per ogni altra forma di «lettura», quali la musica, il teatro, la danza, il cinema e le arti visive, incluse l’architettura, la fotografia o persino espressioni più pop, come il fumetto, i programmi televisivi, la stampa quotidiana. Nei dodici metri quadri della sua cella di Turi, Gramsci leggeva avidamente i romanzi d’appendice di Sue e della Peverelli. Chiamava tutto questo «razzolare nella spazzatura», alla feconda ricerca delle visioni del mondo che alimentavano la cultura popolare.
Oggi possiamo permetterci di essere meno schizzinosi. Snoopy non è forse un maître à penser di facile consumo ma di grande profondità? La Fenomenologia di Mike Bongiorno di Umberto Eco non è stata un piccolo oblò da cui osservare la società di massa, e dunque noi stessi e il nostro «divenire», la nostra bildung? Hegel definiva la lettura del giornale il sostituto moderno della preghiera del mattino: come dargli torto? Non vedrei male, in qualche università, un corso monografico sul pensiero di Snoopy destinato a indagare i nostri stili di vita. Il calcolo enigmatico di un settimanale che vanta migliaia di tentativi (falliti) di imitazione non è forse un corso di logica in miniatura? E gli impareggiabili rebus del medesimo settimanale non sono il capitolo di un possibile trattato di semiotica? Insomma, la filosofia è dappertutto; paradossalmente, la più arida è quella pretenziosa che si ascolta nelle aule universitarie, tra gli addetti ai lavori.
Fin qui considerate questo articolo come uno spot a favore di un approccio «filosofico» a qualunque genere di «lettura», non necessariamente visuale. Forse qualcuno di questi generi è più nobile di altri, ma nessuno merita di essere snobbato. Nella seconda parte, più che offrirvi un esempio, voglio proporvi una sorta di «compito a casa», perché vi esercitiate.
Nella seconda metà del ‘600 circolò clandestinamente un testo antireligioso, il Trattato dei tre impostori, corrispondenti ai fondatori delle grandi religioni monoteistiche. Oggi questo trattato può forse soddisfare qualche ateo di quelli tosti, ma come chiave ermeneutica l’impostura non spiega nulla circa le religioni. Ho appena ultimato un romanzo, I fratelli Fiedland di Daniel Kehlmann, che invece si presta a riflettere in materia di impostura. Potremmo anzi sottotitolarlo come Trattato dei cinque impostori: un padre, Arthur, votato all’insuccesso come scrittore con il proprio nome e su temi a lui cari, ma – dopo essersi sottratto al suo mondo – si scopre destinato al successo come estensore di romanzi che non sente suoi e pubblicati sotto pseudonimo; un ipnotizzatore, Lindemann, che sfrutta le passioni più recondite degli spettatori per tirare a campare; il figlio maggiore, Martin, avuto da una relazione effimera, che dopo la fuga del padre e i primi insuccessi amorosi, cerca rifugio nella religione cattolica e nella bulimia, facendosi prete senza avere fede e ingrassando a dismisura senza avere fame; i gemelli Eric e Ivan, che Arthur ha avuto dalla moglie, apprezzato medico, e che diverranno il primo un consulente finanziario, infedele tanto con la moglie quanto soprattutto con i suoi clienti, che depreda sistematicamente pur di avere un successo che sente in ogni caso estraneo, come ogni altra persona o cosa, e il secondo un critico e mercante d’arte, omosessuale, che lancia in orbita un ignoto pittore, delle cui opere egli stesso, artista mancato, diviene l’autore segreto.
Per un certo tempo l’impostura paga. La crisi finanziaria del 2008 segna però una svolta, e fa maturare il momento del redde rationem per tutti. L’esplosione della bolla speculativa coincide con l’esplosione di cinque vite e di cinque diverse imposture. Dei destini dei protagonisti, vi anticipo solo quello di Lindemann, il più ovvio e il meno interessante; gli spettatori si assottigliano, la vista e la mente divengono più confuse, l’arte si appanna e i redditi smagriscono. Quanto agli altri destini, li scoprirete da soli, se seguirete il mio consiglio.
L’impostura, questo il senso del libro, domina le nostre vite. Ciò accade per una visione prestazionale della vita, che ci impone di aderire all’ideologia e alle ritualità del «successo», o, come nel caso di Martin, di rifugiarci in un insuccesso protetto dalla Chiesa, dalla madre e dal cibo, e che lascia al protagonista una sola ostinata speranza di riscatto, quella di vincere un concorso di abilità nel comporre correttamente e nel minor tempo possibile il cubo di Rubik, benché ormai passato di moda.
L’impostura è qualcosa di più della menzogna, della dissimulazione e dell’ipocrisia. È una reiterazione che lentamente ci intrappola, e dalla quale non possiamo più uscire: una postura che non è la nostra, che assumiamo per sfuggire a circostanze e stati emotivi difficili, che ci premia e insieme ci devasta, al punto che vi è una sola attesa possibile per poterne uscire: che la verità si disveli, che la postura finalmente sia così insostenibile da indurci a lasciare che di botto si dissolva, o esploda, proprio come una bolla finanziaria. Ma cadute infine tutte le imposture, nessun membro della famiglia è in grado di reperire in sé, o nel passato, una qualche parola di verità. Restano in piedi altre recite, o l’effimera via di fuga del sogno. Di questo meccanismo siamo tutti vittime e carnefici, debitori e creditori, pagatori a prezzi salati e beneficiari. I fratelli Friedland, il loro padre Arthur e il signor Lindemann costituiscono altrettanti modelli antropologici del nostro tempo, tutti simili e tutti diversi.
Il lettore si sente sollevato dal sarcasmo, talora caustico e sempre comico, che accompagna il racconto. Con questo non è però affatto autorizzato a dirsi: – Ma per fortuna io non sono così! Deve, in qualche misura, interrogarsi: in che misura sono partecipe di questa malattia sociale, o come complice o come vittima o come l’una e l’altra cosa? E in che misura posso e possiamo uscirne?

You must be logged in to post a comment Login